Il dilemma degli operatori umanitari, tra sicurezza ed efficacia

Le organizzazioni umanitarie cercano di trovare una risposta di fronte agli attacchi sempre più numerosi contro il loro personale sul terreno. Un difficile esercizio d’equilibrismo per cercare di raggiungere il massimo di efficacia e garantire nello stesso tempo la sicurezza.
Siria, Iraq, Libia, Ucraina: da alcuni anni a questa parte mesi gli operatori umanitari pagano un tributo sempre più pesante per adempiere alla loro missione. Alcuni casi hanno particolarmente scioccato, come l’esecuzione dell’ostaggio statunitense Peter Kassig da parte dei jihadisti dell’autoproclamato Stato islamico in Siria.
«La sicurezza è un tema che ci preoccupa molto», sottolinea Peter Staudacher, di Caritas Svizzera, organizzazione attiva in diversi paesi in guerra o in situazioni difficili. «Per realizzare dei progetti e assicurare la sicurezza degli operatori umanitari nelle zone di conflitto sono necessari una pianificazione e un budget speciali», continua.
Per Terre des Hommes, organizzazione che fornisce, tra le altre cose, servizi umanitari ai siriani e agli iracheni rifugiati in Libano, Giordania e Kurdistan (nord dell’Iraq), la situazione è la stessa. «In materia di sicurezza, prendiamo misure che ci permettono di evitare danni sia intenzionali che accidentali, afferma l’incaricata della comunicazione Zélie Schaller. Questa politica non ci permette di evitare tutti i pericoli, ma grazie ad essa possiamo valutare la situazione sul terreno per ognuna delle nostre missioni e elaborare un piano di sicurezza per proteggere i nostri collaboratori».
La sicurezza rappresenta una sfida quotidiana anche e soprattutto per il Comitato internazionale della Croce Rossa (CICR), attivo in più di 80 paesi. «Oggi in Siria, in Iraq o in Libia, i problemi legati alla sicurezza sono numerosi e concernono molta gente», afferma Dibeh Fakhr, portavoce dell’organizzazione.
Un’equazione difficile
In ambito umanitario, assicurare la protezione dei collaboratori rappresenta un difficile esercizio d’equilibrismo.
Proteggerli senza perder di vista il risultato auspicato costituisce infatti un’equazione difficile da risolvere.
Peter Staudacher ne è cosciente e precisa: «Sul terreno non bisogna cercare di raggiungere ad ogni costo il risultato che ci si era prefissati. Ciò che conta, è una valutazione costante della situazione, per permettere di separare ciò che è necessario da ciò che lo è meno».
Rispettare l’equilibrio tra sicurezza ed efficacia non è semplice, conferma Dibeh Fakhr. «Discutere con tutte le parti in conflitto richiede a volte molto tempo e le negoziazioni sono difficili. Siamo spesso obbligati ad accontentarci di un minimo di garanzie se vogliamo soccorrere chi ha bisogno di noi. Oggi vi sono molte regioni a cui non possiamo accedere perché non abbiamo un’autorizzazione».
Disfarsi dei segni distintivi?
Costruire dei muri sovrastati da filo spinato o limitare il margine di manovra degli operatori umanitari sono soluzioni che senz’altro possono contribuire a migliorare la sicurezza. Ma anche a scavare un fossato tra le organizzazioni umanitarie e chi beneficia dei soccorsi.
In linea generale, una politica dissuasiva è accettabile solo se è utilizzata «per salvare vite o convogliare aiuti suscettibili di evitare una catastrofe», sottolinea Peter Staudacher. Il ricorso alla protezione armata «spinge gli abitanti del posto a considerare le organizzazioni umanitarie come facenti parte della stessa ‘barca’ manovrata dalle forze stranieri sul posto», aggiunge.
Obbligate a dar prova di discrezione, le organizzazioni umanitarie devono a volte disfarsi dei loro segni distintivi, ad esempio il logo in bella mostra sugli autoveicoli. Questo modo di agire può però creare una certa ambiguità sull’identità dell’organizzazione e suscitare sospetti tra i lavoratori locali. Secondo Dibeh Fakhr, non esiste una formula magica che può essere applicata a tutte le situazioni difficili, che variano da un paese all’altro. «Lavorare in Iraq non è come lavorare in Libia o nello Yemen. Per ogni paese ci vuole una strategia specifica».
Collaborare con la popolazione locale
Terre des Hommes ha preferito optare per l’apertura piuttosto che per la forza. «La maggior parte dei nostri collaboratori è originaria dei paesi in cui siamo attivi. Questa scelta ci permette di identificare meglio i bisogni locali e di elaborare in seguito i nostri progetti», spiega Zélie Schaller. Anche per Peter Staudacher questa collaborazione con le collettività locali è importante. «Tuttavia bisogna vegliare a non esporle a pericoli», sottolinea.
Il CICR cerca anche lui di «adattarsi ai costumi e ai metodi di lavoro» del paese in cui è attivo, osserva Dibeh Fakhr. Sul posto, l’istituzione collabora coi suoi partner, le organizzazioni nazionali della Croce Rossa o della Mezzaluna Rossa, per realizzare i suoi progetti e negoziare con le parti in conflitto.
Esistono però anche altri mezzi per migliorare la sicurezza e rafforzare nel contempo l’aiuto alle popolazioni nei paesi sinistrati: campagne di sensibilizzazione, ascolto e dialogo con gli abitanti e gli organismi locali.
(traduzione e adattamento di Daniele Mariani)

In conformità con gli standard di JTI
Altri sviluppi: SWI swissinfo.ch certificato dalla Journalism Trust Initiative
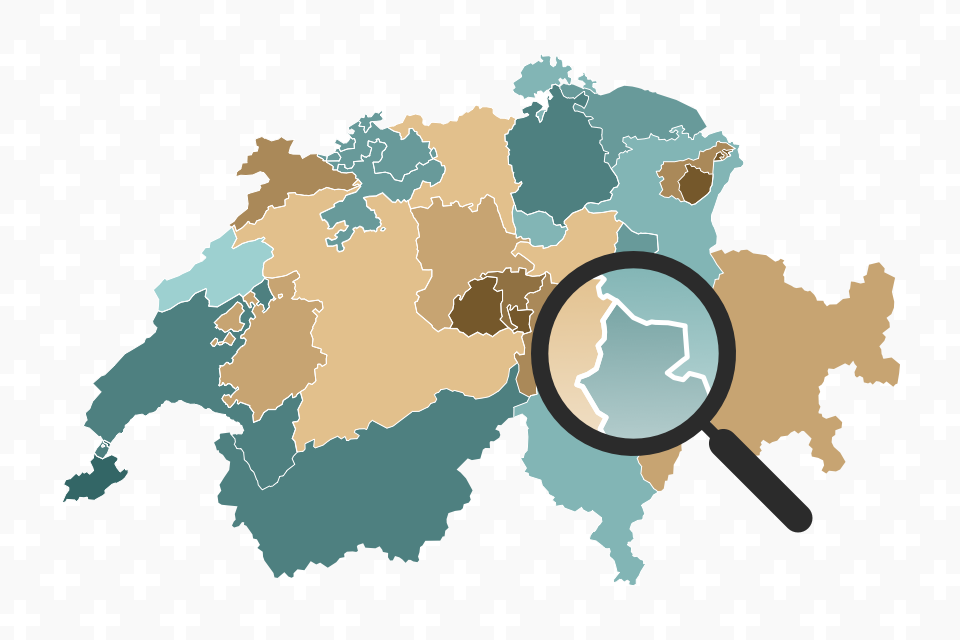











Potete trovare una panoramica delle discussioni in corso con i nostri giornalisti qui.
Se volete iniziare una discussione su un argomento sollevato in questo articolo o volete segnalare errori fattuali, inviateci un'e-mail all'indirizzo italian@swissinfo.ch.