Bambini schiavi: un giudizio severo su un severo sistema di assistenza

La Svizzera è confrontata con un capitolo buio della sua storia recente: i collocamenti forzati dei cosiddetti “bambini schiavi”. Gli attori coinvolti sono spesso ridotti a stereotipi: autorità crudeli e famiglie affidatarie approfittatrici. Raramente viene però menzionato l’altro principale colpevole: la povertà.
Fino al 1981 in Svizzera 100mila bambini sono stati strappati ai loro genitori e collocati in famiglie contadine o in istituti. Poca attenzione veniva data ai loro bisogni affettivi e non esistevano meccanismi adeguati per proteggerli da abusi e abbandoni.
Malgrado le carenze del sistema di assistenza, non tutti gli attori coinvolti hanno agito con consapevole negligenza nei confronti dei bambini. La società era confrontata con gravi problemi sociali e pregiudizi, in particolare contro i figli illegittimi e le famiglie più povere.
Qual era dunque il contesto economico e morale della Svizzera della metà del Ventesimo secolo, che ha favorito lo sviluppo di un approccio così duro nei confronti dell’infanzia?

Altri sviluppi
Collocamenti forzati: i “bambini schiavi” si raccontano
La maggior parte degli adulti autorevoli di quel tempo – genitori, insegnanti, avvocati, rappresentanti dell’ordine religioso – sono deceduti e non possono più spiegare le loro azioni. Le loro testimonianze sono praticamente assenti. Le ricerche sul tema dei bambini schiavi, avviate una decina di anni fa, si basano dunque essenzialmente sui racconti delle vittime e sui documenti d’archivio.
La storica Loretta Seglias ha cercato di comprendere in che modo le comunità sono intervenute per assistere le famiglie più povere e le “ragazze madri”, con o senza il loro consenso. Nella metà del secolo scorso, «una buona fetta della popolazione svizzera viveva ancora in condizioni di estrema povertà», annota.
Sostenere queste famiglie rappresentava una sfida finanziaria e organizzativa non indifferente. Invece di versare delle prestazioni sociali, la risposta abituale era quella di sottrarre uno o più bambini al nucleo famigliare e collocarli in un istituto o nelle famiglie di contadini.
«La società era convinta che questi bambini dovessero imparare a lavorare. A scopo pedagogico, venivano dunque collocati laddove potevano apprendere un mestiere, in modo da riuscire poi a sovvenire ai loro bisogni, senza dover chiedere nulla alla comunità».
Un inizio difficile
Roland Begert è un insegnante di economia ormai in pensione e vive alla periferia di Berna. Ben istruito e vestito in modo elegante, non lascia trasparire alcun segno della battaglia che ha affrontato. Dato in affidamento nel 1937, quando era ancora neonato, Begert ha trascorso la sua vita cercando di far luce sui lati oscuri della sua infanzia.

Il padre era un alcolizzato e un vagabondo, mentre la madre apparteneva alla comunità di nomadi Jenish. Cresciuta in un istituto, non aveva le risorse sufficienti per prendersi cura dei figli. Così, tre settimane dopo il parto – abbandonata dal marito – ha dato in affidamento Roland e il fratello maggiore, di soli due anni.
«Non aveva altra scelta. Prima di tutto non aveva soldi e poi non aveva imparato alcun mestiere. Più tardi ho capito che mia madre aveva un carattere debole e passivo, non certo i presupposti per un’educazione felice».
Begert è stato collocato in un orfanotrofio della Chiesa cattolica romana, nel canton Soletta, dove ha trascorso i primi dodici anni di vita. In totale, 280 bambini sono stati cresciuti da 25 suore, non retribuite. L’orfanotrofio, come molti altri, era finanziato da donazioni private e gestito con pochi soldi.
Abusi sessuali
Con così tanti bambini da gestire e un’educazione fondata sulla disciplina, non vi era spazio per l’affetto, ricorda Begert, che nell’istituto ha subito più volte abusi sessuali da parte di altri ragazzi. Una violenza che ha percepito per molto tempo come una tappa normale della crescita.
«Alcuni ragazzi tornavano in istituto dopo un affidamento andato male. Sono loro ad averci introdotti nel mondo della sessualità e non certo in modo piacevole. Le suore sapevano, fino a un certo punto, ciò che stava succedendo, ma non avevano nessuna idea di come gestire la situazione».
All’età di 12 anni, senza alcun preavviso, Begert è stato mandato da una famiglia di contadini. «Non c’era affetto, ma per lo meno rispetto. Io li rispettavo e non per paura. Ho sentito subito che erano grandi lavoratori, che avevano dovuto lottare per sopravvivere. Ricevevano 30 franchi al mese per me e allo stesso tempo potevano contare su una manodopera a basso costo. Funzionava così allora».

Altri sviluppi
È giunta l’ora, forse, della riparazione
Dal 1877, una legge federale vietava l’impiego nelle fabbriche di bambini al di sotto dei 14 anni. Ma gli altri settori non erano regolamentati e soprattutto nell’agricoltura il lavoro minorile era ampiamente tollerato. «Questa era la realtà per molti bambini in Svizzera», afferma la storica Loretta Seglias
Collocamenti non ufficiali
I bambini collocati dalle autorità non erano gli unici costretti a lasciare casa. Talvolta erano le stesse famiglie, spesso poverissime, a trovare degli arrangiamenti per poter arrivare a fine mese. Nel 1952, in un piccolo villaggio del canton Friburgo, Christina è stata mandata a vivere per due anni dal vicino, la cui moglie era malata. All’epoca aveva dieci anni.
«L’uomo chiese ai miei genitori se avevano una ragazza che poteva accudire la moglie, che aveva problemi psichici, e tenerle compagnia dato che lui era spesso assente.», ricorda l’anziana signora.
Quando erano le autorità a collocare i bambini, il contatto con i genitori era sconsigliato. Spesso questi non sapevano nulla delle condizioni di vita e di salute dei loro figli.
«Questi bambini erano collocati presso sconosciuti e negli anni Cinquanta il controllo non era ancora conforme alla legge», afferma Seglias. «Ciò significava che il rischio di abusi e violenze era più grande perché nessuno badava per davvero a questi bambini».
Stigma

Altri sviluppi
«Mi hanno rubato la giovinezza»
Alla fine della Seconda guerra mondiale, la legge svizzera è stata modificata ed è stato introdotto ufficialmente il termine di “famiglie affidatarie”. Ai genitori venivano rimborsate le spese di mantenimento. Legalmente e sulla carta, non vi erano più bambini schiavi o Verdingkind, come venivano chiamati in tedesco. In realtà però ci sono voluti decenni prima di porre fine allo sfruttamento.
«Ciò è legato allo sguardo che la società aveva su questi bambini. Era come se portassero uno stigma per il fatto di essere poveri, nati al di fuori di un matrimonio, con genitori alcolizzati o con problemi mentali. Questo stigma era messo dai genitori ai figli», afferma la storica Seglias.
Begert ha trascorso quattro anni con i suoi genitori affidatari, facendo gran parte del lavoro agricolo al di fuori dell’orario di scuola.
Malgrado i buoni risultati scolastici, e il desiderio del suo maestro di mandarlo alla scuola secondaria, Begert è stato tagliato fuori dal sistema scolastico per decisione dell’ispettore. Ha seguito un apprendistato come operaio all’età di 16 anni. Per otto anni «infernali» ha guadagnato solo qualche spicciolo. La sua paga finiva nelle mani della proprietaria della pensione, come d’accordo col suo tutore. Oggi in pensione, Begert ha scritto un libro sulla sua esperienza e si batte affinché giustizia sia fatta.
Dopo essere stati dimenticati per anni, i “bambini schiavi” si sono finalmente visti riconoscere ufficialmente come “vittime” da parte della Confederazione, che sta discutendo della possibilità di garantire un fondo di “riparazione”. Un’iniziativa popolareCollegamento esterno in questo senso è stata lanciata nel marzo 2014 e chiede la creazione di un fondo di 500 milioni di franchi. Toccherà dunque probabilmente al popolo pronunciarsi sul tema.
Begert non chiederà un risarcimento, poiché ritiene che «per lui non cambierebbe nulla». Riconosce però che questo fondo potrebbe essere utile per le vittime, incluso suo fratello. La cosa più importante, conclude, è che l’opinione pubblica si renda conto di quanto successo e che la protezione dei bambini non sia mai più rimessa in questione.
(Traduzione dall’inglese, Stefania Summermatter)

In conformità con gli standard di JTI
Altri sviluppi: SWI swissinfo.ch certificato dalla Journalism Trust Initiative


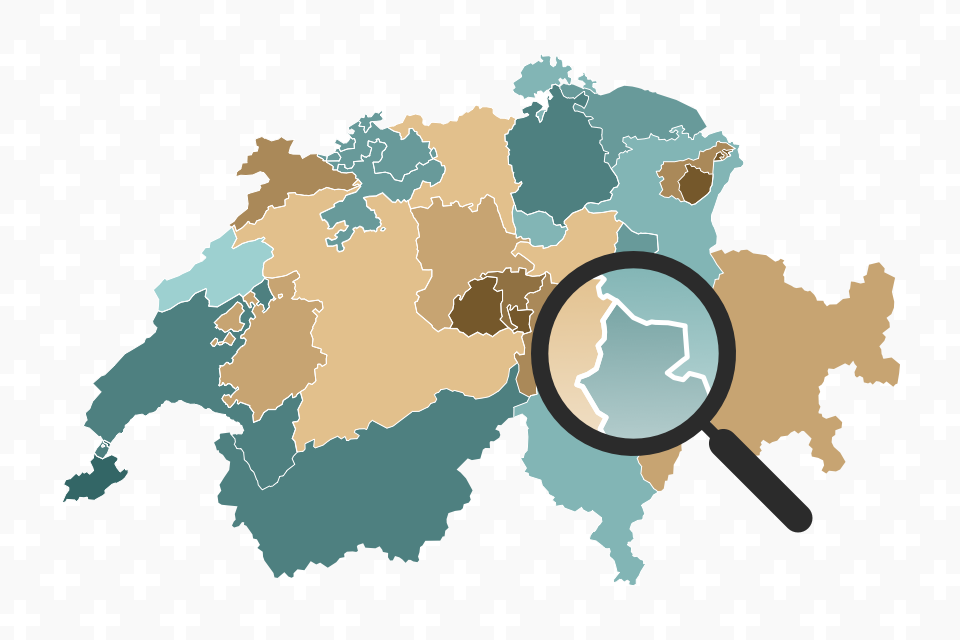









Potete trovare una panoramica delle discussioni in corso con i nostri giornalisti qui.
Se volete iniziare una discussione su un argomento sollevato in questo articolo o volete segnalare errori fattuali, inviateci un'e-mail all'indirizzo italian@swissinfo.ch.