Tremila pagine sull’atteggiamento della Svizzera di fronte ai regimi nazifascisti

Gli otto primi volumi del rapporto finale della commissione Bergier, presentati giovedì, spaziano dagli accordi di clearing fra Svizzera e potenze dell'asse al commercio di opere d'arte in fuga o confiscate, passando per una serie di temi soprattutto di natura economica. Un breve riassunto dei temi affrontati.
Inizialmente la CIE avrebbe dovuto occuparsi, come noto, solo del tema dei fondi in giacenza nei conti delle banche svizzere. Ma sull’argomento si doveva già chinare la commissione Volcker, dotata di un solido budget di alcune centinaia di milioni, rispetto ai quali i 22 milioni spesi per la commissione Bergier non sono poi gran cosa.
Supportata dal mandato governativo che gli conferiva ampio accesso agli archivi pubblici e privati e da una forte domanda di chiarezza su vari aspetti dell’atteggiamento della Svizzera negli anni attorno alla Seconda guerra mondiale, la CIE ha così allargato il suo approccio. Sono rimasti centrali, come si constata anche dagli otto volumi ora presentati, i temi economici, ma non sono mancate esplorazioni in altri ambiti.
Clearing e Interhandel
Di un tema centrale per le relazioni economiche fra la Svizzera e le potenze dell’Asse si occupa il volume redatto da Stefan Frech, dedicato al traffico dei pagamenti (clearing). Stipulati nel corso degli anni Trenta con Germania e Italia, gli accordi di clearing inserirono in pieno la Svizzera nello spazio economico del nuovo ordine europeo. Nell’ambito degli accordi, la Svizzera concesse prestiti per 1,121 miliardi di franchi alla Germania e di 290 milioni all’Italia. I crediti servirono ai due paesi soprattutto per l’acquisto di materiale bellico in Svizzera. Per l’autore una chiara violazione della neutralità elvetica.
Durante gli accesi dibattiti a metà degli anni Novanta sul ruolo della Svizzera nel conflitto mondiale, un nome aveva fatto ripetutamente capolino: quello della Interhandel. Nata a Basilea nel 1928/29 (fino al 1945 con il nome di IG Chemie)come holding finanziaria del gruppo tedesco IG Farben e investita della proprietà di importanti stabilimenti chimici negli USA, la Interhandel fu oggetto di un’aspra battaglia giuridica nel dopoguerra.
Nel 1942 gli USA avevano confiscato le fabbriche della IG Chemie sul proprio territorio, ritenendole patrimonio del nemico. Ma nel dopoguerra i proprietari svizzeri rivendicarono i beni confiscati, sostenendo la completa separazione fra IG Farben e IG Chemie dal 1940. Lo studio di Mario König permette ora di fare maggiore chiarezza sulla complessa vicenda, in cui a partire dalla fine degli anni Cinquanta ebbe un ruolo chiave l’Unione di Banche Svizzere (UBS).
Chimica ed elettricità
Gli studi di Jean-Daniel Kleisl, rispettivamente di Lukas Straumann e Daniel Wildmann, si occupano invece delle relazioni delle industrie elettriche e chimiche svizzere con il Terzo Reich. Anche qui vengono alla luce gli stretti rapporti economici tra i due paesi ed il sostanziale orientamento al profitto, indipendentemente dal contesto politico in cui agivano, delle imprese elvetiche.
Le industrie chimiche basilesi prese in esame – Geigy, Ciba, Hoffmann-La Roche e Sandoz – operavano in territorio tedesco nella piena consapevolezza, secondo gli autori, della situazione politica ed economica, integrando le informazioni disponibili nelle loro strategie aziendali. Ciò, assieme agli ottimi contatti con le gerarchie governative naziste, permise loro di mantenere una notevole libertà di manovra. Una libertà che a volte poteva anche rappresentare una limitata resistenza alle direttive naziste: così in Germania la Roche licenziò i suoi impiegati ebrei solo nel 1937/38, quattro o cinque ani dopo le sue “consorelle”.
Per quel che riguarda l’industria elettrica, lo studio di Kleisl mette in rilievo l’importanza delle forniture elvetiche al Terzo Reich, dalla metà degli anni Trenta il primo cliente per volume di importazioni delle compagnie elettriche svizzere. Secondo l’autore, le forniture elettriche ebbero un ruolo preponderante nel far desistere la Germania nel 1943 dal lanciare un’offensiva economica contro la Confederazione.
Lavoro forzato, stampa, ferrovie, opere d’arte
Gli altri quattro studi si occupano rispettivamente dell’impiego di lavoratori forzati da parte delle imprese svizzere nel Terzo Reich (Christian Ruch, Myriam Rais-Liechti, Roland Peter), dell’atteggiamento della stampa elvetico rispetto alle questioni dei rifugiati e della politica commerciale (Kurt Imhof, Patrik Ettinger, Boris Boller), del transito ferroviario attraverso la Svizzera negli anni della guerra (Gilles Forster) e del trasferimento e passaggio di opere d’arte in fuga o depredate in Svizzera (Esther Tisa Francini, Anja Heuss, Georg Kreis).
Lo studio sul lavoro forzato, pur non avendo la pretesa di offrire una sintesi globale della questione e analizzandola anzi solo in termini esemplari, promette di offrire molti elementi di novità. L’analisi dei documenti conservati negli archivi delle aziende ha infatti permesso agli autori di capire le informazioni e l’influsso che le case madri in Svizzera avevano sull’impiego di lavoratori forzati nelle loro filiali nel Reich. Smentita la tesi giustificatoria, secondo cui le filiali in Germania sarebbero rimaste isolate dalle case madri, lo studio mette d’altro canto in rilievo il grado di integrazione delle imprese svizzere nell’economia di guerra tedesca.
Per quel che riguarda il transito ferroviario, il volume di Forster pare mettere definitivamente fine alle ipotesi avanzate di recente sul transito di deportati diretti nei campi di concentramento tedeschi attraverso le trasversali ferroviarie elvetiche. Rimane aperta invece la questione del passaggio di materiale bellico: l’autore non esclude che, stanti limitati controlli da parte elvetica, i vagoni piombati trasportassero anche armi.
Con il lavoro dedicato al commercio di opere d’arte, i collaboratori della CIE affrontano un tema anch’esso molto discusso in anni recenti. Un elemento di novità è l’accento posto sui “beni in fuga”, un concetto creato dagli autori per indicare le opere d’arte trasferite in Svizzera per sfuggire alla confisca da parte delle autorità naziste. Dallo studio risulta che in Svizzera entrarono nel complesso più beni in fuga che opere depredate. Una parte del libro si occupa inoltre della politica seguita dalla Svizzera nel dopoguerra in materia di restituzione dei beni artistici e culturali.
Per quel che riguarda l’atteggiamento della stampa, la cui analisi è stata affidata ad un gruppo di ricercatori attorno al professore zurighese Kurt Imhof, risulta infine il ruolo piuttosto marginale dei temi “profughi” e “politica commerciale” nella stampa elvetica durante la guerra e l’ampio consenso verso il concetto di Svizzera come paese di transito e non paese d’asilo.
Andrea Tognina

In conformità con gli standard di JTI
Altri sviluppi: SWI swissinfo.ch certificato dalla Journalism Trust Initiative

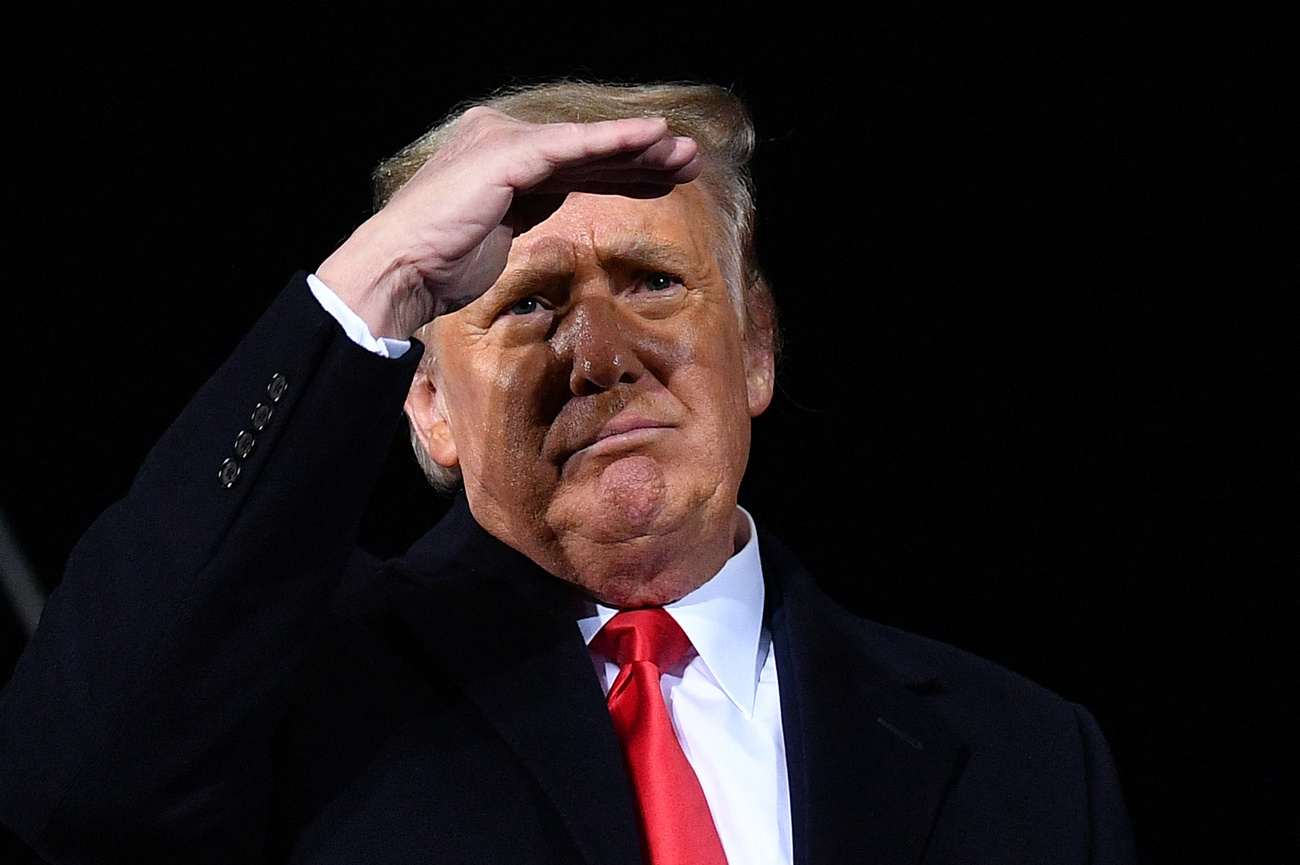






Potete trovare una panoramica delle discussioni in corso con i nostri giornalisti qui.
Se volete iniziare una discussione su un argomento sollevato in questo articolo o volete segnalare errori fattuali, inviateci un'e-mail all'indirizzo italian@swissinfo.ch.